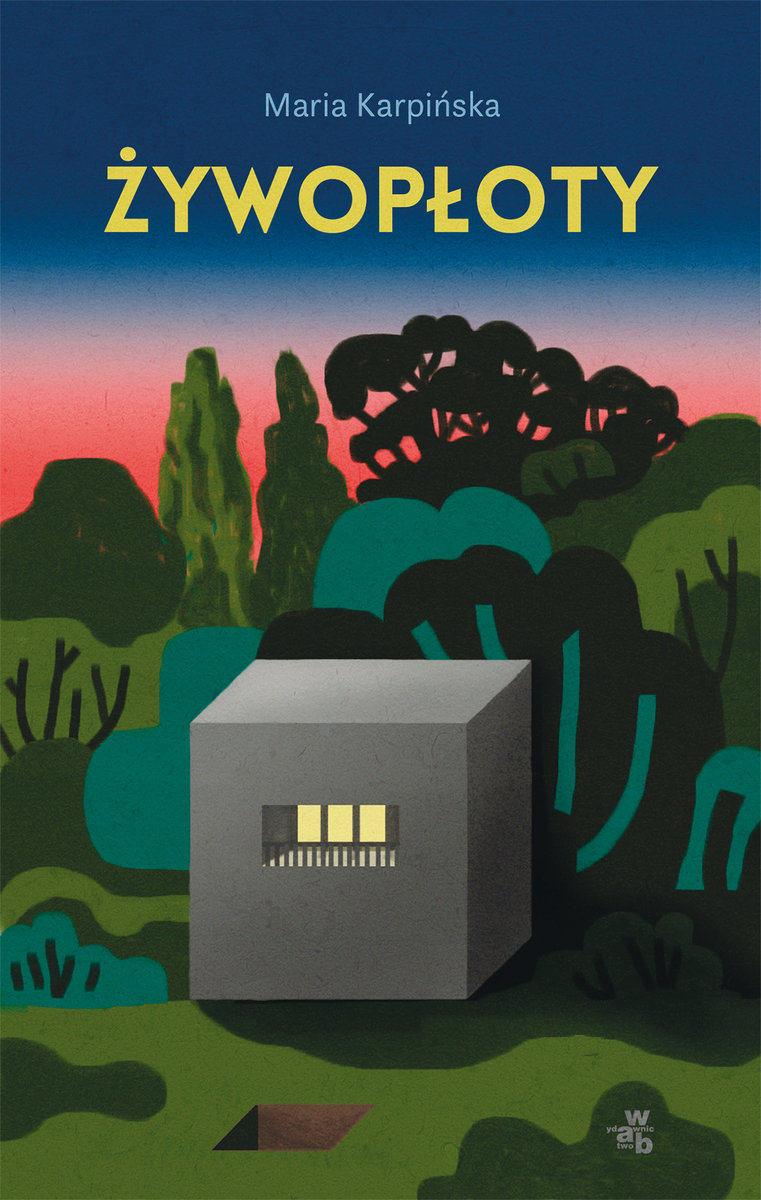Premiato con il Nike nel 2017, Żeby nie było śladów parla dell’assassinio da parte della polizia di Jaruzelski del giovane Grzegorz Przemyk.
–
di Salvatore Greco
–
In un giorno di maggio un diciannovenne decide di fare un giro in centro con un gruppo di amici per festeggiare la fine degli esami di maturità. Ritenuto troppo rumoroso e trovato senza documenti, viene fermato dalla polizia, condotto in commissariato per l’interrogatorio. Alle domande si alternano calci, pugni e manganellate. Il ragazzo, congedato, finisce velocemente in ospedale dove muore due giorni dopo. Nei giorni, mesi, anni successivi il dolore della famiglia e la volontà di giustizia di chi gli sta attorno si scontrano con la rete di omertà e autodifesa dei corpi di polizia e di chi li gestisce.
La storia di Żeby nie było śladów, reportage di Cezary Łazarewicz uscito per Czarne nel 2016 e fresco vincitore del prestigiosissimo Premio Nike, si può in fin dei conti riassumere nelle poche righe qui sopra. Una storia di violenza e di impunità poliziesca come ne conosciamo amaramente troppe, a partire dai casi nostrani di Stefano Cucchi o Federico Aldovrandi per citare solo i più noti. Ma è una storia, quella che racconta Łazarewicz, che in Polonia conosce connotati simbolici molto più marcati e dolori molto più capillari e diffusi. Perché i fatti del libro sono accaduti nella Polonia del 1983, in uno stato di legge marziale sospesa ma non ancora ufficialmente abrogata; perché Grzegorz Przemyk non era, suo malgrado, un qualsiasi liceale ma il figlio di una (modesta) poetessa e vivace attivista dei movimenti di opposizione; perché la polizia che lo ha caricato di forza e ammazzato di botte in commissariato era l’espressione più odiosa di quegli anni, i corpi anti-sommossa dello ZOMO alle dirette dipendenze del ministro degli interni Czesław Kiszczak, il secondo uomo più potente della PRL dopo il solo generale Jaruzelski.
Lo stesso titolo di Żeby nie było śladów (che si può tradurre come “senza lasciare tracce”) è una frase che Cezary F., amico di Przemyk e testimone chiave del processo ha sentito pronunciare a uno dei poliziotti protagonisti del pestaggio del suo amico. L’ordine era di picchiare, e picchiare duro, ma in modo che non fosse chiaro che le responsabilità fossero della polizia. Un intento, come vedremo, solo parzialmente riuscito.
Piotr Bratkowski, critico e penna dell’edizione polacca di Newsweek, riportato sulla quarta di copertina del volume dice una cosa che rende straordinaria chiarezza sul modo in cui Żeby nie było śladów è stato accolto dai lettori:
“Leggo vari libri a settimana, ma erano anni che non ne leggevo uno con le lacrime agli occhi e questo nonostante il resoconto fatto da Łazarewicz dell’omicidio di Grzegorz Przemyk sia stato scritto senza l’ombra di sentimentalismo e in larga parte sia basata su crudi rapporti e documenti raccolti negli anni”.
Ma che libro è davvero Żeby nie było śladów? Che presa può avere il reportage di una storia nota, in Polonia, pressoché a tutti? E cosa può significare la conquista del premio Nike, per la prima volta dedicato a un reportage? Proviamo a capirlo.
Non mi uccise la morte, ma due guardie bigotte mi cercarono l’anima a forza di botte
Il primo grandissimo merito di Łazarewicz in questo libro è la capacità di tenere le distanze da una storia il cui coinvolgimento emotivo collettivo è evidente parlando con la gente per le strade di Varsavia anche oggi che sono passati trentatré anni dai terribili fatti. Sarebbe insomma comprensibile, e forse perdonabile, se Żeby nie było śladów fosse un libro di santificazione della vittima e maledizione dei carnefici. In verità Grzegorz Przemyk non è un santo, ma un ragazzo normalissimo, e la madre Barbara Sadowska una donna piena fino al collo di umani difetti e incapacità sociali che Łazarewicz decide saggiamente di non nascondere, ché questa Polonia di martiri impeccabili non ha bisogno, ma di verità storica sì.
 Nel libro si alternano le vicende che, giorno dopo giorno, partono dal 12 maggio del fermo in piazza e seguono il processo fino alla fine, e le storie umane degli altri protagonisti di questa storia sbagliata. È soprattutto la storia personale di Barbara Sadowska il contraltare delle cronache del 1984, la storia di una donna che si ritrova madre senza averne bene coscienza, insegue il sogno un po’ bohemien di una vita da poetessa senza obblighi di altra sorte, è incapace di trovare un lavoro “normale”, fatica a inquadrarsi in orari e compiti, nella casa in cui cresce un neonato invita a più riprese artisti e attivisti dell’opposizione che vi si incontrano come in un locale clandestino. Sono queste le pagine in cui Łazarewicz si permette di allentare un po’ le cinghie del rigido racconto processuale fatto di carte, dichiarazioni e ricordi e lasciare sfilare un po’ più morbida una penna sorprendentemente gradevole e narrativa. L’arresto, il pestaggio e la morte di Grzegorz sono taglienti e reali come un referto, il dolore e la complessità di Barbara lo sono come li sa ricreare uno scrittore di professione.
Nel libro si alternano le vicende che, giorno dopo giorno, partono dal 12 maggio del fermo in piazza e seguono il processo fino alla fine, e le storie umane degli altri protagonisti di questa storia sbagliata. È soprattutto la storia personale di Barbara Sadowska il contraltare delle cronache del 1984, la storia di una donna che si ritrova madre senza averne bene coscienza, insegue il sogno un po’ bohemien di una vita da poetessa senza obblighi di altra sorte, è incapace di trovare un lavoro “normale”, fatica a inquadrarsi in orari e compiti, nella casa in cui cresce un neonato invita a più riprese artisti e attivisti dell’opposizione che vi si incontrano come in un locale clandestino. Sono queste le pagine in cui Łazarewicz si permette di allentare un po’ le cinghie del rigido racconto processuale fatto di carte, dichiarazioni e ricordi e lasciare sfilare un po’ più morbida una penna sorprendentemente gradevole e narrativa. L’arresto, il pestaggio e la morte di Grzegorz sono taglienti e reali come un referto, il dolore e la complessità di Barbara lo sono come li sa ricreare uno scrittore di professione.
Lo spazio entro il quale la vita del giovanissimo Przemyk viene interrotta e spezzata dura nel libro poco più di venti pagine che si leggono con la perentorietà di telegrammi inviati dal fronte. Frasi rapide, spezzate, dure, flash da un fotoreportage di morte. La storia che si dilunga per le successive quasi trecento di pagine è quella di uno Stato in affanno che all’ordine del giorno ha l’esigenza pressante di smarcare sé stesso e il suo braccio armato da un omicidio gratuito che l’opinione pubblica occidentale e la stampa clandestina potranno usare per ribaltare l’ordine costituito.
E allora inizia un’opera meticolosa di depistaggio, calunnia, corruzione di prove che deve servire a dimostrare l’indimostrabile: Przemyk non è morto per via delle percosse dei poliziotti e, anche se fosse, era un individuo pericoloso figlio di una madre degenerata. E così si avvicendano pian piano nel racconto le vicende: quella dei paramedici dell’ambulanza che portarono Przemyk al pronto soccorso, calunniati, incarcerati, quasi convinti a confessare un improbabile -anche secondo i medici legali consultati- pestaggio in ambulanza; quella delle urla di dolore del giovane sentite da dietro una porta dall’amico Cezary F. durante l’interrogatorio spiegate come accompagnamenti delle mosse di judo con cui Przemyk avrebbe attaccato la milizia; quelle dello stesso Cezary F. costretto a darsi alla macchia e soggetto a un sottile e orwelliano (davvero sinistra la coincidenza di vivere questi eventi nel 1984) lavaggio del cervello orchestrato da delatori e spie dei servizi segreti -compreso il suo stesso padre- per fargli confessare un’altra verità prima laboriosamente rielaborata.
Riunioni di gabinetto, interventi in procura, conversazioni private e racconti di prima mano sono elementi che Łazarewicz ha raccolto con meticolosità e precisione nelle fonti per ricostruire al meglio possibile una storia che, chissà quante volte raccontata, rischia di allontanarsi dalla realtà fattuale. In un momento in cui una certa classe politica polacca preferisce abbozzare sui fatti per accelerare sulle santificazioni, una sana rivolta contro le semplificazioni è fondamentale.
E una rete fondamentale l’autore la segna sul finale, nella zona Cesarini del suo densissimo libro, andando a cercare la storia e le ragioni di Ireneusz Kościuk, uno dei miliziani autori del pestaggio, mai condannato per omicidio. Kościuk viene da una periferia smarrita e abbandonata dalla quale l’unica via d’uscita e di riscatto sociale passa non dall’istruzione o da prospettive professionali, ma dall’arruolamento negli ZOMO. Per la sua piccola comunità ai margini, Kościuk è uno che ce l’ha fatta, ha raggiunto la capitale, è uscito dal buco nero altrimenti insuperabile che condanna i nati fuori dai gangli economici e politici del mondo. Quello che è successo poi, è una brutta storia di cui nessuno ama parlare. Ma se una macchia c’è, è comunque la macchia di uno che ce l’ha fatta, anche a discapito di un quasi coetaneo morto ammazzato per non avere con sé i documenti e per essere figlio della donna sbagliata.
Le ragioni del Nike
Il premio Nike è oggi il premio letterario più importante in Polonia e in venti edizioni ha premiato prevalentemente romanzi o raccolte di poesie, Żeby nie było śladów è il primo reportage a vincerlo. E nel Paese di Kapuściński e Hanna Krall, è una cosa che fa rumore.
Il libro di Łazarewicz che con molte semplificazioni abbiamo provato a riassumere fino a poche righe fa ha vinto per la capacità di giostrare i registri, di essere un reportage senza peli sulla lingua o velleità cristologiche fuori tempo massimo, di raccontare eventi noti senza annoiare e senza esserne un corollario morale non richiesto. Nella Polonia del 2017 in cui Adam Michnik e lo stesso Lech Wałęsa passano molto tempo sulla graticola mediatica e sono oggetto di accuse, per tacere delle calunnie, è chiaro che il mito di Solidarność e della stagione del tramonto della PRL stanno affrontando una fase di rivalutazione. Non tanto una rivalutazione degli assi portanti politico-economici, che per altro è stata fatta tempo fa da menti lucide, ma nel portato di un’eredità culturale e politica di stampo liberale oggi messa in discussione dal pensiero espresso dal partito di governo. Gazeta Wyborcza, quotidiano fondato da Michnik e aperto oppositore del governo, è co-promotore del premio Nike sin dalla prima edizione e non è illegittimo immaginare che il premio a Łazarewicz vada interpretato come il tentativo della Polonia liberale di non cedere del tutto la palma di oppositori del comunismo e autentici “patrioti” agli uomini di PiS ma anche e soprattutto di condannare sottilmente uno Stato -di qualunque colore esso sia- zelante nell’occupare ogni casella di potere e capace di governare i media, le istituzioni, i tribunali. I riferimenti all’attualità e alle scelte dell’esecutivo sembrano insomma evidenti e il monito di questo Nike appare ben chiaro visto sotto questa luce: il problema non è il potere concentrato nelle mani dei comunisti, ma il potere in sé, chiunque lo detenga senza appello.