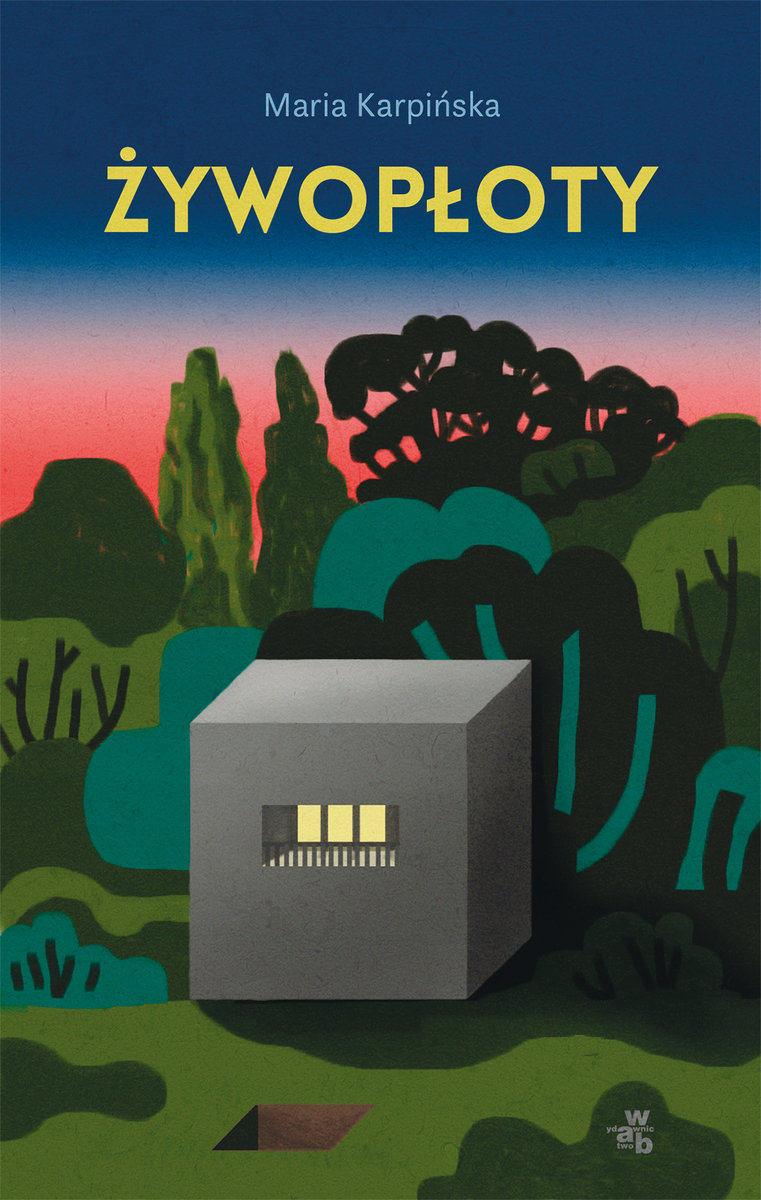Il brano che segue è tratto dal romanzo Baśń o wężowym sercu di Radek Rak (Powergrah, 2019). Tutti i diritti appartengono a Radek Rak e a Wydawnictwo Powergraph.
I diritti per la traduzione italiana sono liberi e gestiti in esclusiva da Nova Books Agency s.c.
Per informazioni: agent@novabooksagency.com
La traduzione dal polacco è di Francesco Annicchiarico.
Continua da qui.

Del cuore per l’ennesima volta
Si dice che una femmina pretenda ogni cosa dal proprio uomo, e un uomo soltanto una cosa dalla femmina; il che a volte è sacrosanta verità, e altre una gran bella sciocchezza.
Dopo quella notte Kuba temeva che Malwa sparisse, una volta e per sempre, lasciandolo con un pugno di ricordi in mano e con la fame nel cuore, una fame che non avrebbe conosciuto pace. O la paura che diventasse qualcosa di peggio: Malwa sparita e la testa così piena di incantesimi da non potersi mai più ricordare di lei.
Successe qualcosa del tutto diversa e molto più grave.
Poco prima della festa del raccolto arrivò improvvisamente il freddo. Piovve e tutto si gonfiò di umido. Odore di muffe e funghi dal bosco. Kohlmann aveva persino cominciato ad accendere la stufa, perché la notte a sua moglie gelavano i piedi.
Nel giorno della festa, sin dal mattino la locanda sussultava di chiacchiericci e scalpiccii. Le femmine portavano pani e focacce al miele fatte con la semenza nuova, l’odore di pane e cumino profumava l’intera taverna. Le mele cuocevano sui fornelli, le patate nella cenere sotto di esse, polli e galline arrostivano sugli spiedi, si erano scocchiumati i primi barili di birra novella. Era una buona annata e niente mancava.
Il grasso sfrigolava e il vapore denso saliva alto, si sarebbe detto più un santuario che una locanda. Non più griglie e carboni, ma un altare sacrificale non per il pallido, smunto Dio dei cristiani, ma per il grasso, vecchio e possente Dio degli ebrei. In tutto questo scompiglio, Rubin Kohlmann si dimenava a destra e manca, carico di profetico trasporto. Controllava la cottura delle carni, assaggiava la birra e lo spirito, urlava e rimbrottava, chemiprendauncolpo, tanto che sembrava ce ne fossero dieci di Rubin, anziché uno. C’erano molte donne intorno a lui, come in ogni santuario non potevano mancare. C’erano le figlie Kohlmann, alcune goy di shabbat e le contadine, visto che in tempo di raccolto anche le padrone più virtuose aiutavano alla locanda degli ebrei.
Kuba non riuscì a piluccare nemmeno un pezzetto di quelle squisitezze, ché Kohlmann e Vecchio Topo gli affibbiavano di che sbattagliare ogni cinque minuti. Prima gli avevano fatto pulire il cortile, poi aveva imbiancato la staccionata e per finire aveva dovuto imbracare il castrone tarchiato per andare fino a Brzostek, alla farmacia di Łukasiewicz, a prendere olio e spirito per i liquori di assenzio e aneto, come usavano fare i cechi. Kuba doveva spicciarsi, ma gli riuscì comunque di adocchiare Malwa, che si affaccendava insieme alle altre femmine. Tanto gli bastava. Non era scappata da nessuna parte.
La spedizione gli prese tutto il giorno. Sebbene Brzostek fosse il paese più vicino, la strada era lunga, tutta sotto il sole, una volta in salita, un’altra in discesa e alla fine zacchera di fango e pioggia. Inoltre, il castrone era testardo e irascibile, sembrava più un mulo che un cavallo.
Arrivati ai piedi della collinetta su cui si ergeva la cittadina, l’animale si era rifiutato di collaborare. Immobile, col muso appeso e l’occhio vitreo, e Kuba che lo spingeva e batteva con lo scudiscio. Kuba era dovuto scendere dal carro e arrampicarsi da solo lungo il sentiero ripido e viscido di fango. Alla vista di un altro carro, un po’ più su, immobile al centro del sentiero e con un bue incastrato nell’asse rotto, al cavallo in qualche modo saltò la pulce all’orecchio. L’animale muggiva, i garretti guizzavano nella mota, impossibile che ce la facesse a uscire da lì.
Kuba non ebbe il minimo riguardo all’acume del suo ronzino. Era accecato dalla furia e ce l’aveva con qualsiasi cosa: col sentiero di fango, in cui si affondava a ogni passo, col vecchio Kohlmann che l’aveva messo su quella strada, col vossignoria eccellenza dignitaria a cui era destinato il liquore di erbe secondo l’uso dei cechi, con le mosche che gli davano il tormento perché la giornata era umida e afosa. E col tempo che gocciolava via malefico, attimo dopo attimo, tempo che lui avrebbe potuto trascorrere insieme a Malwa.
Tale era la sua rabbia meschina.
Superò senza una parola il contadino che invocava aiuto, quello con il bue impantanato, e arrivò alla piazza del mercato. Brzostek non era una grande città: sei strade, tra cui quella principale che portava da Plzen a Jasło, una chiesa con il tetto a cipolla, case basse di argilla giallastra, la piazza del mercato, una taverna e una macelleria ebraica; tutto qui. Kuba trovò subito la farmacia di Łukasiewicz e comprò il necessario. Sulla strada di ritorno oltrepassò una gazzarra attorno al carro in mezzo al sentiero. Il contadino si lagnava che il bue alla fine si era spezzato i garretti e tutti aspettavano che arrivasse il macellaio per finirlo. Il rimorso gli esplose in una fitta allo sterno, perché un bue del genere non era mica una perdita da niente; ma tutto sommato l’animale non era suo, e perciò Kuba smise subito di darsene il pensiero.
La damigiana di spirito non pesava troppo e, a dire il vero, non ci sarebbe stato tutto questo bisogno di imbracare un carro intero, se solo Brzostek fosse stata un po’ più vicina. In quel caso Kuba avrebbe dovuto inevitabilmente caricarsi la damigiana sul groppone. Senza neanche darsi il tempo di riflettere, il ragazzo sferzò il cavallo per indurlo a prendere la strada di ritorno. Via verso il bosco di faggi, per i campi falciati di fresco, per montagne e colline, via come un fulmine, come un lampo tra le braccia di Malwa!
Il ronzino non pareva avere la sua stessa fretta. Mica strano, tutto ciò che l’attendeva alla locanda era la solita stalla buia e un po’ di foraggio umido, perché la paglia dello scorso raccolto non era ancora asciutta a dovere. Approcciò dunque un trotto mesto, avanzando titubante prima sulle zampe sinistre, poi sulle destre, grufolando un disappunto profondo, che irritò Kuba ancora di più.
Il ragazzo si contorceva al suo posto, come se avesse preso i vermi. Gli si fece la gola secca, quindi diede un sorso al bottiglione. Quello spirito ceco era di colore verde, lo stesso che prende il cielo al tramonto dopo un temporale. Bruciava, ardeva le budella, gli fece venire le lacrime; impossibile da mandar giù. Kuba mescolò lo spirito verde con l’acqua del ruscello, metà e metà, e così ce la fece. Al secondo bicchiere, quasi gli piaceva. Ne allungò un po’ anche al cavallo, che però sbuffò e rifiutò.
«Ah, scemo d’una bestia. Ma guardatelo, sdegnare lo spirito dei signori.» Kuba sputò e ingollò da solo, stavolta dritto dal bottiglione, tanto, un paio di bicchieri dopo, quello strano liquore non bruciava più come prima. Gli venne il terrore alla vista dello spirito che diminuiva sempre più nella damigiana. Meno male che gli venne da pisciare, così mise l’uccello nel collo della bottiglia e mirò al centro del liquido. Il liquore cominciò piano piano a cambiare tinta, ma non tanto da destare attenzione.
Restava ancora un miglio fino alla locanda di Kohlmann, forse uno e mezzo. La strada proseguiva un po’ per il bosco e un po’ per dei frutteti incolti, perché molto tempo prima, quando questa era ancora Polonia, non molto distante da qui si trovava un maniero. Il ronzino si fermò di punto in bianco, aizzò le orecchie, sbuffò e cominciò a tirare dritto tra i meli adunchi. Era di certo preso dal raggiungere le cotogne per terra, ma Kuba era sicuro che lo facesse per pura cattiveria.
«Aspetta, un momento, oh! Dove vai! Fiiiiuuuu!!!»
Il cavallo non perse tempo ad ascoltare e tirò il carro dritto al frutteto. Un ramo frustò Kuba dritto in faccia e lui che si incazzò nero, tirò le briglie e si lanciò a picchiare il ronzino, che si mise a nitrire e scalpicciare sul posto. Kuba menava con la cinghia come un ossesso, fino a farlo sanguinare.
Allora qualcosa colpì il ragazzo dritto sul grugno. Sentì come un morso di vipera.
Ma non era una vipera.
«Cosa stai facendo, cafone, picchi il tuo animale?»
Un vossignoria sbucato dal nulla di fronte a Kuba. Adorno di giacca chiara dagli ampi risvolti, montava un cavallo grigio stretto di fianchi. A Kuba, le lacrime che gli colavano negli occhi sciolsero la visione in una suggestione d’acquerello e il cavaliere col suo destriero emanava un’inusuale luminosità, come appena spuntato da un’immagine sacra. Il ragazzo chinò il capo di lato per mettere a fuoco. La vossignoria si concesse la libertà di fustigarlo ancora.
«Non ti contorcere tanto, allocco.»
Kuba in ginocchio di fronte al vossignoria, implorava e frignava come facevano i contadini. Ebbe persino l’ardire di afferrare il sottopancia con una mano e baciare la punta dell’illustre stivale. Vossignoria lo scalciò con disgusto, dritto nei denti.
«Taci. Sbriglia quel cavallo. Muoversi.»
Kuba staccò il cavallo dall’asse. Pensava solo a cosa gli sarebbe toccato dire a Kohlmann, solo che quel vecchio ebreo era lontano, e il signore era vicino, quindi c’era da dar retta al vossignoria. Il ronzino dimenava felice la coda e puntava verso gli alberi alla ricerca di mele. Qualche istante dopo sparì tra l’erba alta. Si sentiva solo lo scricchiolio dei rami.
«Metti quel giogo», ringhiò il vossignoria. «Cosa guardi, fannullone di un ottuso? Il giogo, ho detto».
Quindi Kuba eseguì l’ordine. S’imbrigliò lui stesso al carro e prese la strada. Il nobiluomo, fiero e soddisfatto, procedeva giusto accanto schizzando grumi di fango. Continuarono così per circa duecento passi, quando dagli alberi riemerse di nuovo il castrone. Che ruttò soddisfatto, come preso da un ticchio d’appoggio.
Il ronzino si arrampicò sul sedile del carro e afferrò il frustino tra lo zoccolo inzaccherato e il garretto per scudisciare lo svogliato Kuba. Il ragazzo si sforzò tanto che gli vennero le vene alle tempie, e cominciò a tirare il carro. Pesante lo era davvero, ma cominciò a muoversi; meno male che era in discesa e poco distante dalla locanda. Al vederlo, il vossignoria scoppiò a ridere e cominciò ad avanzare anche lui.
Dalla locanda provenivano già i cori e le risate, i musici intessevano le melodie di danze vivaci. Il giovane Kuba lasciò il carro nel grande fienile, che nel tempo d’estate fungeva anche da stalla per mucche e cavalli. Il ronzino dovette calare la testa per non rompersi la testa sullo stipite. I due restarono immobili lì dov’erano.
«Basta, no? Che ne dici? Scendi da lì», sbuffò Kuba sganciandosi dal giogo. «Ora tu, bestiaccia malfidata, dovresti spazzolarmi e farmi mangiare, non appena riprendo fiato. E fare bere un po’ d’acqua non troppo fredda, così non mi si gonfia la pancia.»
Il ronzino ragliò come se volesse riderne, e si mise a scendere dal carro. Prima di arrivare nel suo vano, pigiò col muso il fianco di Kuba, come a dirgli che tutto è uno scherzo, solo per non farlo infuriare. Kuba gliene disse di tutti i colori, e dopo si mise a pettinargli groppa e coda, così non si facevano nodi al crine. Le due mucche decrepite gli lanciarono una lunga occhiata indifferente, prima di ripiombare nel solito oblio, come fanno le mucche quando sono sotto un tetto.
Si sentì un leggero scricchiolio, quando la porta si spalancò. Qualcuno entrò.
«Il cavallo ha fatto il viaggio seduto.»
La voce di Chana non sembrava sorpresa, perché Chana raramente si stupiva di qualcosa. Spostò su Kuba gli occhi neri, abissali. In quell’istante sembrava la terza mucca della stalla.
«Però, c’hai messo poco. Il cavallo seduto al mio posto, niente male. E io, forse ho tirato io il carro?»
Silenzio. Quel silenzio che preme ai fianchi e stringe da qualche parte dentro. Grasp, grasp, la spazzola dura raspava il fianco del cavallo.
«Mungi tu le vacche, Chana? Ché mi serve, per la sala…»
Era una stupida bugia, perché a Kuba non serviva proprio niente. Aveva solo una gran fretta di raggiungere Malwa e lo sapevano entrambi, sia Chana che lui.
La giovane ebrea allora annuì, si sfilò di tasca un fazzoletto bianco, lo annodò in fronte, prese uno sgabello e si mise alla mungitura serale. Il ragazzo uscì senza dire una parola e sospirò profondamente. Sentiva qualcosa tra il fegato e lo sterno, proprio dove si trova l’anima, ma ignorò il sintomo. Aveva solo Malwa nella testa e non c’era posto per altri pensieri.
Si sciacquò la faccia e le mani con l’acqua del pozzo nel cortile e si affrettò alla baracca dei goy per cambiarsi la camicia. Il tessuto di lino gli pizzicava sotto le ascelle. La camicia era ancora fresca, la portava solo da due giorni.
La festa continuava allegramente. La locanda rimbombava fino al tetto per le risate, i canti e la musica, e una massa di maschi e femmine si allungava fino alla strada, pareva che la festa traboccasse fuori dall’ostello come il latte caldo da un pentolino. Kuba si fece largo fino al centro della baraonda, spintonando qualche contadino. Uno voleva azzuffarsi con lui, ma i fumi della birra novella gli arrivavano già alle orecchie, ché a stento si teneva in piedi; altri due provarono a trattenerlo e il contadino gli vomitò addosso.
Jontek Gaca e gli altri musicisti suonavano come se gli archetti gli bruciassero tra le dita, come se quella melodia non dovesse finire mai. Le giovani femmine gironzolavano ovunque, incaricate da sole di portare le vivande e le bibite, perché così, si capisce, era più facile farsi notare dai maschi. La prima tra loro era Salcia Niewiaroska e non aveva da portare niente, perché col dondolare dei suoi fianchi scemuniva tutti i maschi, e non solo i giovanotti e gli scapoloni di campagna, ma anche i vecchi e gli ammogliati. Non ne aveva alcun bisogno, ma lo faceva per risultare ancor di più sulle altre, perché questa è la natura delle femmine.
Kuba non cadde nella malia, o per lo meno non del tutto. Squadrava ovunque alla ricerca di Malwa. Eccola! Imporporata in viso, variopinta da non riconoscerla. Quella sera persino i suoi capelli avevano preso tutti i colori, ed erano le tinte della luna. Kuba avrebbe voluto farsi largo e raggiungerla attraverso la folla, ma guardò meglio e un terrore animalesco lo strinse lì dove prima.
Malwa portava un vassoio, e su questo c’erano dei bicchieri massicci, splendidi, i più meravigliosi che il vecchio Kohlmann possedesse. Lei li reggeva, li stava portando al vossignoria.
Il vossignoria Wiktoryn sedeva spaparanzato al centro della sala, a ogni presepe il suo Erode. Fumava sigarette, sghignazzava e si attorcigliava il baffo, attorniato dal suo crocchio di leccapiedi: un baciapile, il cocchiere dei ricchi e un nugolo di femminette. Ogni virgola caduta dalle illustri labbra del vossignoria fioriva in una risata allegra degli accoliti; quando comandò qualcosa con speciale premura, tutti intorno a lui assentirono tanto volentieri da non sembrare nemmeno più buon cristiani, ma ebrei salmodianti.
Malwa pose il vassoio coi bicchieri davanti a vossignoria Wiktoryn, tra questi c’era il liquore verde, proprio quello che Kuba aveva portato da Brzostek. Gli ospiti al tavolo, poco familiari con gli usi dei ricchi, guardarono con sospetto quel liquore, ma il vossignoria incitò tutti a berne. Tutti s’ingargarozzarono, ad alcuni andò di traverso, tossicchiarono e sputacchiarono talmente che sembravano volessero rimetterci l’anima. Kuba pensò fosse una fellonia che i più illustri servi del circondario crepassero tutti insieme. Wiktoryn e i suoi leccapiedi si sbellicavano, Kohlmann batteva le mani e dietro così anche le femminette, prima piano e poi quando fu chiaro che non era veleno, risero fino a scoppiare, come sanno fare solo le femmine.
Vossignoria Wiktoryn si chinò verso Kohlmann, che scattò arrivando con una scodella piena di zucchero a zollette di Cechia e una brocchetta d’acqua di pozzo. Vossignoria artigliò la radiosa Malwa per mettersela sulle ginocchia. Poi allungò la mano a due bicchierini di alcol verde, uno per sé, l’altro per la ragazza ammaliante, e a mano propria vi aggiunse acqua fino al colmo. Zuccherò parecchio, strofinò uno zolfanello al tacco della scarpa e accese i liquidi. Il beverone appiccò con una fiamma bluastra e avvampò per un lungo istante, finché le fanciulle si chinarono tutte verso Malwa. Lei e il vossignoria presero i bicchieri, soffiarono le fiamme e ingollarono fino alla goccia.
«Così si fa, cafoni!» esclamò Wiktoryn appagato. E tutti ne risero, e Malwa più di tutti, sguaiata e arrochita come una baldracca.
Un bicchiere dopo l’altro. Bevvero tutti gli ospiti più illustri e zuccherando a volontà, dato che mica sempre gli capitava di bere gli spiriti da signori, e finanche lo zucchero. Anche il vecchio Kohlmann beveva, persino i musicanti. E nessuno, nessuno si accorse che era uno spirito allungato di piscio.
Nascosto in un angolino, Kuba temeva che il suo trucchetto venisse scoperto, ma temeva qualcos’altro ancora di più.
A quel tavolo dei ricchi tutti erano già cotti di spirito. Soltanto Malwa continuava a calare bicchierino dopo bicchierino, come fosse stata acqua. Vossignoria Wiktoryn la agguantò e provò a baciarla, troppo cotto per accorgersi che Malwa non era la solita femminetta, perché la solita femminetta sarebbe già cascata come una pera cotta, a quell’ora.
E Kuba nel suo angolo si mordicchiava le unghie, perché c’era troppa gente al tavolo per poter semplicemente andarci e levargli Malwa dalle grinfie. Stava bevendo la solita acquavite da villici, e gli si allargava in petto un’ombra fumosa come bitume rovente. L’ombra gli invase gli occhi e il cuore e non riuscì più a vedere niente.
Quel giorno danzavano i diavoli nella locanda di Kohlmann.
Chiunque era ubriaco quando Kuba infine uscì a pisciare. La notte si stagliava altissima e i cani sbraitavano per la campagna. Il gruppetto aveva smesso di suonare da molto. Uno di loro dormiva placido sotto una panca, con un rivolo di acquavite che gli scorreva sulla faccia. Jontek Gaca, che suonava il liuto, raggiunse ben felice Salcia Niewiarowska, di schiena a un palo, completamente nuda e indifferente a ciò che le stava per succedere; i maschi dovevano averle messo le gocce nel bicchiere, ossia l’etere.
Kuba non si curò minimamente di quel che accadeva, lui che di solito si vergognava per qualsiasi cosa e arrossiva peggio di una femmina. Rientrò nella locanda, dove recuperò un coltellino da intaglio conficcato in un ciocco. Lo tirò via con forza per poi lanciarlo nel legno a mo’ di prova. Era un buon coltello e aveva un bel peso in mano. Il ragazzo ritornò fuori, per sgozzare il vossignoria e chiunque altro gli si fosse piazzato davanti.
E così successe che la prima di tutti fu Malwa. Forse stava andando a cercare quel vino di mele che tenevano nascosto, o forse qualcosa del tutto diverso.
«Che tieni lì?» interrogò Kuba.
Il ragazzo rimirava il coltello da ogni lato.
«Niente.» e lo nascose dietro la schiena.
«Buttalo.»
«Che ha lui che io non ho?»
La ragazza fissò Kuba e in quel suo sguardo non c’era l’ombra di colore o di espressione. Nessun essere umano è capace di uno sguardo così e a Kuba gli prese una strizza mica da poco.
«Lui ha la forza», rispose tranquilla. «Ha il potere. Quando parla, tutti gli danno retta. E tu? Tu sei bello, e neanche lui è così brutto. Tu puoi darmi qualcosa che lui non ha?»
Disse proprio così. E forse non avrebbe dovuto, perché in tutta risposta Kuba si aprì la camicia e s’infilzò il coltello nel petto fino al manico. Tirò a destra, tirò a manca, scavò nella ferita e si strappò via il cuore. Gli batteva in mano, scuro nel buio della notte, grondante sangue e linfa grumosa.
Kuba diede il cuore a Malwa senza dirle una parola. La ragazza lo guardò con i suoi occhi di colore dell’acqua. Poi prese il dono e andò via.