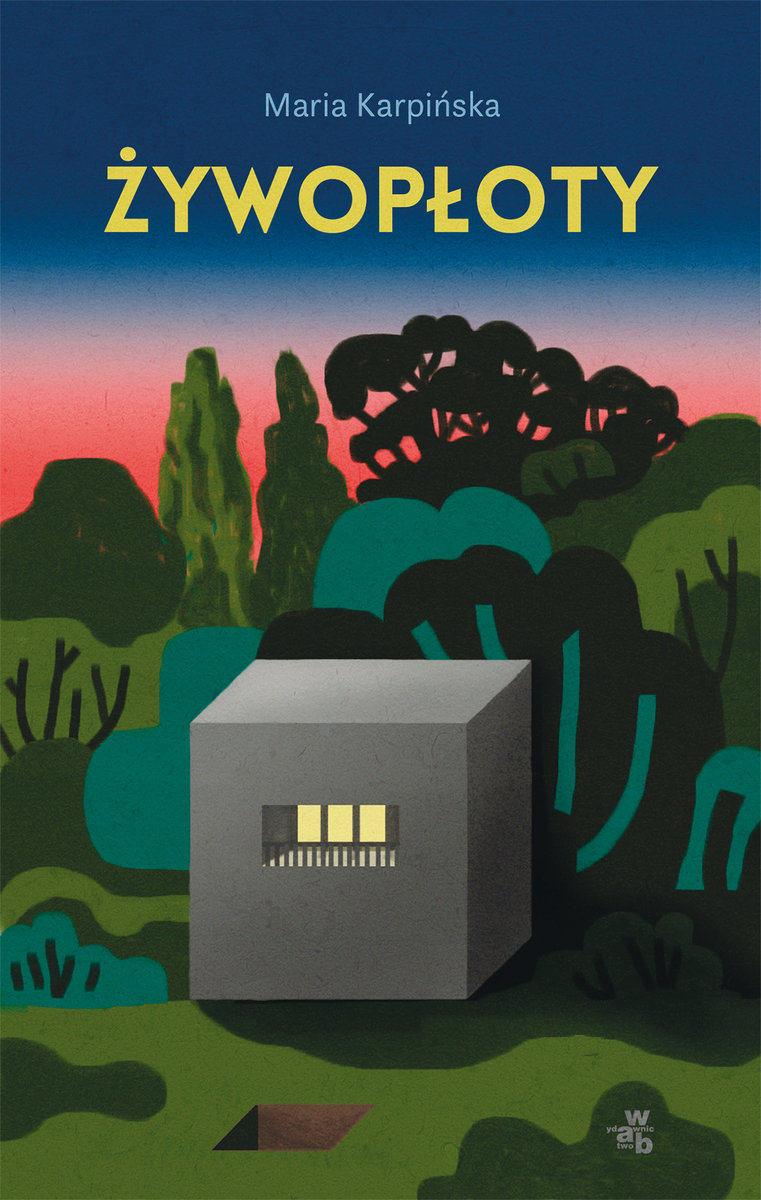Per un’architettura etica: il padiglione polacco alla Biennale di Venezia 2016
–
di Roberto Reale
–
Nel febbraio 2014 Zaha Hadid, a chi le domandava cosa gli architetti possano fare per limitare le morti bianche tra i lavoratori dell’edilizia, rispondeva che la questione era di competenza del governo, non sua (Marcus Fairs, Preventing migrant deaths at Qatar stadium site “not my duty as an architect” says Zaha Hadid, in Dezeen, 26 febbraio 2014). E questo a fronte di un costo umano valutato, da un’inchiesta apparsa su The Guardian appena un mese prima (Owen Gibson, More than 500 Indian workers have died in Qatar since 2012, figures show, in The Guardian, 18 gennaio 2014), in oltre 500 incidenti mortali nel cantiere del nuovo stadio di Al Wakrah, in Qatar, il cui progetto portava la firma della stessa Hadid.
La dichiarazione destò sconcerto, anche perché in controtendenza rispetto alle voci autorevoli che già da qualche anno si erano levate a chiedere di incorporare una dimensione etica, prima ancora che nelle legislazioni sul lavoro, nel processo stesso dell’architettura. Tom Spector, nel suo libro The Ethical Architect: The Dilemma of Contemporary Practice (Princeton Architectural Press, 2001), articola l’istanza etica all’interno della triade vitruviana firmitas utilitas venustas. Anche Richard Rogers e Daniel Libeskind avevano parlato di responsabilità dell’architetto e di accettabilità, in termini etici prima che funzionali o formali, del progetto.
Il contributo polacco alla XV edizione della Mostra Internazionale di Architettura di Venezia, chiusa il 27 novembre 2016 (è possibile visitare virtualmente il padiglione della Polonia su Google Arts & Culture), fa propria questa presa di coscienza, ma ne sovverte radicalmente il punto di vista. Chiedersi se un’architettura etica sia possibile non è più un esercizio filosofico intorno al ruolo dell’architetto, inteso classicamente come origine e fulcro di tutto il processo architettonico; ma è un’attività estremamente concreta, un’urgenza pragmatica, a cui dare soddisfazione scendendo direttamente in cantiere, interrogando gli operai e ascoltando le loro testimonianze, vivendo il farsi dell’idea architettonica attraverso i loro occhi.

foto di Maciej Jelonek (all rights reserved)
Così Dominika Janicka, Martyna Janicka e Michał Gdak, curatori della proposta polacca sotto gli auspici della Galleria d’Arte Zachęta, costruiscono attraverso lo spazio del padiglione nazionale un processo maieutico, in cui la pars destruens, un volume saturato da impalcature Innocenti e dalla proiezione di frammenti audiovisuali, denuda dinanzi allo sguardo del visitatore la materia umana del cantiere, invitandolo a una esperienza emotiva e sensoriale prima ancora che a un’adesione di testa, chiedendogli di condividere l’angoscia di un mondo da cui il progettista sembra essere irrevocabilmente assente. La vulgata che vorrebbe l’archistar protagonista indiscusso di tutte le fasi del processo architettonico si rivela ingenua e pericolosa, in quanto distoglie lo sguardo dai costi umani la cui drammaticità va invece sottratta al sommerso che il recinto sacro del cantiere implica; e in quanto impedisce di ascoltare la voce e le storie dei lavoratori dell’edilizia, delle persone “direttamente coinvolte nel processo architettonico” (“osóby bezpośrednio zaangażowany w proces budowlany”, in Nota prasowa PAWILON POLSKI Biennale), questo quinto stato reso più fragile dalla globalizzazione dei mercati e dei flussi di manodopera.
E poi, come in ogni percorso di iniziazione che si rispetti, al visitatore si offre la pars costruens, un grande spazio vuoto “con alcune vedute e una sola grande infografica capace di sintetizzare i numeri di questi fenomeni” (Francesco Pasquale, Padiglione Polonia: costruire equo e solidale, in 011+, 11 luglio 2016) che i curatori intendono qui come un momento di riflessione, non tanto per puntare il dito contro i “responsabili degli abusi nelle varie fasi del processo”, ma per provare a capire “come rendere questo processo non soltanto efficace, ma anche etico” (“jak sprawić, by ten proces był nie tylko efektywny, ale i sprawiedliwy”, in Nota prasowa, cit.).
È possibile costruire secondo un principio di giustizia sociale? Forse sì, rispondono i curatori di Fair Building (è questo il titolo dell’installazione), ma non senza avere la voglia e la disponibilità di scendere a toccare la frontiera viva della condizione umana. E certamente la proposta è in ottima sintonia con il tema complessivo della Biennale 2016, intitolata significativamente Reporting from the Front: giacché, scrive il direttore artistico Alejandro Aravena, “migliorare la qualità dell’ambiente edificato è una sfida che va combattuta su molti fronti, dal garantire standard di vita pratici e concreti all’interpretare e realizzare desideri umani, dal rispettare il singolo individuo al prendersi cura del bene comune, dall’accogliere lo svolgimento delle attività quotidiane al favorire l’espansione delle frontiere della civilizzazione”. Onde “di fronte alla complessità e alla varietà delle sfide che l’architettura deve affrontare, Reporting from the Front si propone di ascoltare coloro che sono stati capaci di una prospettiva più ampia, e di conseguenza sono in grado di condividere conoscenza ed esperienze, inventiva e pertinenza con chi tra noi rimane con i piedi appoggiati al suolo”.
Ben meritato, dunque, il giudizio lusinghiero del New York Times, che cita quella polacca tra le sei proposte da non perdere tra le molte decine che la Biennale tradizionalmente ospita (Hettie Judah, Six Not-to-Miss Shows at the Venice Architecture Biennale, in The New York Times Style Magazine, 23 maggio 2016). Recensioni molto positive anche, tra l’altro, ne Il Giornale dell’Architettura (Roberta Chionne, Polonia: “Fair Building”, 27 maggio 2016), su Dezeen (Amy Frearson, Dezeen’s top 10 pavilions at the Venice Architecture Biennale 2016, 1 giugno 2016) e in The Architect’s Newspaper (William Menking et al., AN Lions: 20 must-see things at the 2016 Venice Biennale, 9 giugno 2016). Leggermente più cauto è The Guardian, il quale è però critico nei confronti dell’intera XV edizione della Biennale, pur riconoscendo al padiglione polacco il merito di aver richiamato l’attenzione su un tema troppo spesso trascurato (Oliver Wainwright, Venice architecture biennale pavilions – a souped-up pre-school playground, 30 maggio 2016) senza tuttavia peccare di ingenuità o buonismo nell’ispirarsi ad alcune delle parole chiave di Aravena (qualità della vita, ineguaglianze, segregazione, insicurezza, migrazione, informalità, igiene, sostenibilità, comunità) (Biennale Architettura: le 5 cose migliori e le 5 peggiori, in Artribune, 1 giugno 2016). Entusiasta, infine, lo sguardo retrospettivo che il sito ufficiale del Ministero della Cultura polacco dedica all’accoglienza tributata, in patria e all’estero, all’installazione: l’esito è definito senza mezzi termini un successo (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Sukces Polaków na Biennale Architektury w Wenecji, 1 luglio 2016; si ricordi, per inciso, che la proposta polacca comprende, oltre al padiglione nazionale, anche un contributo, dal titolo Let’s talk about garbage, all’esposizione comune nell’edificio dell’Arsenale, ed uno alla mostra Time Space Existence a palazzo Bembo).
E nel complesso l’entusiasmo ministeriale, al netto ovviamente di comprensibili ingentilimenti di parte, può essere condiviso. La proposta polacca, infatti, non soltanto accoglie e sviluppa il tema di fondo della mostra, ma riesce ad esprimere un autentico impegno politico su un punto che tocca nel vivo la coscienza nazionale e nello stesso tempo ha interesse a livello globale; il tutto senza impoverire i valori funzionali e formali, ossia propriamente architettonici, del manufatto, la cui qualità di oggetto effimero si realizza anche attraverso un’allusione, non saprei quanto consapevole, alla fragilità del tessuto urbano di Venezia e al suo linguaggio (i tubi Innocenti come pali di fondazione, gli elementi strutturali esposti alla vista, la pervasività dei vuoti).

foto di Maciej Jelonek, all rights reserved
La proposta di Dominika Janicka, Martyna Janicka e Michał Gdak è di spessore perché riesce a sovvertire lo sguardo di vista tradizionale, di ascendenza aristotelica: in prima linea, in cantiere, ci sono gli operai, non l’architetto; sono gli operai che fanno davvero architettura, che ne hanno esperienza diretta, non l’architetto che conosce soltanto il progetto. Fino a che punto, mi chiedo però, possiamo davvero fare a meno di interrogarci sul ruolo che spetta all’architetto, e a nessun altro, nella costruzione di un’architettura etica? Perché, se è vero che la questione etica va affrontata dal basso, è altrettanto vero che la figura dell’architetto costituisce essa pure, nel suo sviluppo storico, l’espressione e l’esito di un processo che parte dal basso.
Estremizzando i termini della questione, l’architetto è il cantiere che prende coscienza di sé, che si fa motore del processo architettonico (il quale nascitur ex fabrica et ratiocinatione, secondo la formula vitruviana) nel momento in cui introduce, a monte della pratica edilizia, la progettazione e il dialogo consapevole con la committenza, del quale interpreta le esigenze attraverso quella sapienza, quell’intendimento che, formatisi sul campo attraverso un processo lentissimo di distillazione, sono tuttavia propri più dell’arte che dell’esperienza empirica (cfr. Maurizio Gargano, Forma e materia, Officina Ed., 2006, passim e in particolare p. 64); e nel rispetto di vincoli materiali, formali, sociali, ed infine etici. Come scrive Paolo Baratta, presidente della Biennale, l’architettura va oggi considerata “in azione come strumento della vita sociale e politica, dove ci si chiede di coniugare a un più alto livello l’agire privato e le pubbliche conseguenze”.
Al contrario dunque del deprecabile disinteresse per le condizioni dei lavoratori dell’edilizia che Zaha Hadid ostentava nell’intervista citata in apertura, è esattamente nella figura dell’architetto che deve incarnarsi la disponibilità a incorporare gli aspetti etici, in modo organico, nel farsi dell’idea architettonica, prima attraverso il gesto progettuale e poi in cantiere; ma prima ancora attraverso il dialogo con la committenza, in particolar modo quella pubblica, nel quale far valere il peso della vocazione, anzi della natura politica dell’architettura.
E in questo senso anche l’architetto è chiamato ad essere in prima linea: svincolato il più possibile da protagonismi fini a se stessi, restituito a una integrità sostanziale, in grado di dare alle idee una forma non soltanto bella e funzionale, ma giusta. Fair building, appunto. Se poi questo processo possa aprirsi a modelli di sviluppo autenticamente comunitari è questione su cui è forse troppo presto per pronunciarsi.
Biografie autori
Dominika Janicka, classe 1986, studia architettura al Politecnico di Danzica e all’École Nationale Supérieure des Arts Visuels de La Cambre (Bruxelles). Collabora con studi d’architettura in Polonia, Belgio, Germania e Cina. È membro del collettivo di design AD12, con il quale realizza numerosi progetti accolti favorevolmente dalla critica: tra gli altri, City Trasformers a Gdynia e Bus with Us (candidato al Dobry Wzór 2014). Dal 2014 dirige il progetto Pracownia Przestrzeni Publicznej (Laboratorio dello spazio pubblico) presso l’Istituto di Design di Kielce.
Martyna Janicka, classe 1991, studia design all’Accademia di Belle Arti di Danzica e alla Glasgow School of Art. Acquisisce esperienza in curatela di mostre durante i Design Days a Gdynia e durante la Milano Design Week; partecipa inoltre al Design Ship, un programma internazionale rivolto all’integrazione di designer provenienti dall’area baltica. Martyna si occupa oggi di ricerca e sviluppo per la Siemens a Monaco di Baviera.
Michał Gdak, classe 1980, studia architettura all’Università tecnica di Delft, all’istituto Vitus Bering (Danimarca) e al Politecnico di Breslavia; studia inoltre scultura presso l’Accademia di Belle Arti di Breslavia e alla Real Academia de Bellas Artes de San Carlos (Valencia). Ha collaborato, tra gli altri, con gli studi OMA, Inter.National.Design, Arne Quinze. Coordina la Scuola di design italiano all’istituto di Design di Kielce.